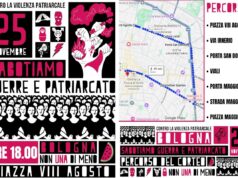Cop30, la trentesima Conferenza mondiale sul clima delle Nazioni Unite si è conclusa il 22 novembre a Belém senza progressi significativi sui principali temi in agenda, in particolare l’adozione di una roadmap globale per l’uscita dalle fonti fossili e un accordo sulla tutela delle foreste.
«La verità è che se non ci stanno gli Stati Uniti, la Cina, l’India e la Russia – osserva ai nostri microfoni Andrea Barolini, direttore di Valori – ti perdi il 70-75% delle emissioni e allora che lo facciamo a fare?». Barolini ha firmato un articolo dal titolo emblematico: “Allora del clima non ve ne frega niente”.
Il flop di Cop30, dove la crisi climatica non sembra più il tema urgente del presente
Nelle prime giornate di lavori, la presidenza brasiliana aveva diffuso testi preliminari che includevano possibili impegni avanzati sul superamento di carbone, petrolio e gas, indicato come obiettivo prioritario della conferenza. Tuttavia, accanto a tali ipotesi figuravano anche numerose alternative meno incisive e diverse proposte di “no text”, modalità con cui alcuni Paesi chiedono di escludere del tutto un tema dal negoziato.
A due giorni dalla chiusura, una nuova bozza ha eliminato ogni riferimento diretto ai combustibili fossili. È così decaduta la possibilità di dare seguito alla formula “transitioning away from fossil fuels”, introdotta alla Cop28 di Dubai.
Secondo osservatori e delegati presenti ai negoziati, l’arretramento sul tema delle fossili riflette la mancanza di un consenso globale. Stati Uniti, Cina, India e Russia, che complessivamente rappresentano la quota principale dei consumi e delle emissioni legati alle fonti fossili, non hanno trovato una posizione comune su un impegno di eliminazione graduale. Le divergenze hanno impedito di avanzare verso un accordo condiviso.
Anche l’Europa si è mostrata ambigua sul tema. «Non si è presentata unita – sottolinea Barolini – perché Polonia e Italia erano contrarie e perché dal G20 la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha affermato che l’Europa non è contraria alle fonti fossili, ma alle emissioni. Frase che non significa niente».
Non sono stati registrati progressi neppure sul fronte della deforestazione, benché la conferenza si svolgesse alle porte dell’Amazzonia. Le trattative si sono concluse senza un accordo su nuovi vincoli o strumenti operativi.
Il documento finale della conferenza contiene alcune misure che, pur presenti, risultano ancora prive di dettagli operativi. Tra queste, la richiesta ai governi di triplicare i finanziamenti per l’adattamento climatico entro il 2035, un obiettivo spostato di cinque anni rispetto a quanto inizialmente previsto. È stato inoltre presentato il Global Implementation Accelerator, un nuovo strumento pensato per sostenere l’attuazione delle politiche climatiche, ma la sua funzione concreta e le modalità di applicazione non sono state chiarite e il suo utilizzo rimarrà volontario.
Nel testo viene anche rivolto agli Stati l’invito a rivedere i propri impegni nazionali di riduzione delle emissioni, considerati insufficienti per mantenere l’aumento della temperatura globale entro 1,5 °C. A questo si aggiunge l’annuncio della “Belém Mission to 1.5°C”, iniziativa che dovrebbe essere definita nei dettagli soltanto alla prossima Cop. È stato inoltre approvato un Just Transition Mechanism, concepito per rafforzare la cooperazione internazionale in favore di una transizione energetica equa. Tuttavia, secondo molti osservatori, tutte queste misure rimangono ancora troppo generiche per incidere concretamente sul percorso climatico globale.
La sessione plenaria conclusiva è stata caratterizzata da momenti di forte tensione. Alcune delegazioni hanno espresso apertamente insoddisfazione per i risultati raggiunti e si sono registrati scambi accesi tra gruppi di Paesi con interessi divergenti, rivelando le profonde spaccature che attraversano i negoziati climatici multilaterali.
Il mancato avanzamento su fossili, deforestazione, finanziamenti e indennizzi per perdite e danni riflete una più ampia difficoltà della comunità internazionale a superare contrasti economici e geopolitici. Da un lato, gli Stati dipendenti dall’estrazione e dall’utilizzo di carbone, petrolio e gas restano contrari a impegni vincolanti per la loro eliminazione; dall’altro, persistono tensioni sulla ripartizione degli oneri finanziari e tecnologici tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo.
ASCOLTA L’INTERVISTA AD ANDREA BAROLINI: